| LA MACCHINA FOTOGRAFICA |
 La
macchina fotografica rappresenta il mezzo meccanico della fotografia ed
è quello strumento che permette di caricare le nostre pellicole,
e di scattare la foto.
La
macchina fotografica rappresenta il mezzo meccanico della fotografia ed
è quello strumento che permette di caricare le nostre pellicole,
e di scattare la foto.
Ci sono diversi tipi di macchine fotografiche, e la maggiore differenza tra loro (o, se non altro, la più evidente) riguarda il formato delle pellicole che possono utilizzare.
Normalmente la maggioranza dei fotografi utilizza macchine che usano pellicole da 35mm che hanno una dimensione di 24x36 mm, ma ci sono apparecchi per formati più piccoli (il 110 e 124) e più grandi 6x4.5, 6x6, ecc.
Chiaramente maggiore è il negativo usato e migliori saranno gli ingrandimenti che potremo ottenere.
Oggi comunque, la qualità raggiunta dalle pellicole 35mm è tale che per la maggior parte degli usi non è necessario usare formati superiori, tranne che per particolari lavori di tipo professionale; inoltre (e non è cosa da poco) il costo delle macchine che usano pellicole di grande formato e' mediamente il triplo di quello di una buona 35mm.
Meritano una nota le macchine di grande formato chiamate Banchi Ottici, che sono molto simili a quelle utilizzate dai nostri bisnonni agli inizi del secolo. Oggi riviste nella meccanica (neanche troppo) permettono il completo controllo dell'immagine, fornendo dei negativi (anche dette lastre) di grande formato (da 6x7 cm a 20x25 cm. ed oltre) facendo ottenere stampe di eccezionale nitidezza e pulizia.
Questi apparecchi oltre ad avere un costo elevato, sono anche particolarmente macchinosi da utilizzare, e per essere usate devono necessariamente essere montate su di uno stativo (grosso e pesante cavalletto), che rende un pò complicato e scomodo l'uso in esterno.
Da cosa e' composta, generalmente
una macchina fotografica? Di solito sono presenti: l'otturatore,
il
mirino, l'esposimetro
L'otturatore, "dosa" il tempo di esposizione della pellicola alla luce. Questo si trova in genere tra l'obiettivo e la pellicola, e ,solamente per le macchine di grande formato, può trovarsi sull'obiettivo anzichè sul corpo macchina. Solitamente gli otturatori sono di due tipi:

Al momento dello scatto l'otturatore
si apre per il tempo predeterminato. Mentre l'apertura dell'otturatore
avviene quasi sempre meccanicamente (tramite una molla che si carica avanzando
il fotogramma), il controllo del tempo può avvenire in due modi:
meccanico
o elettronico. Quello elettronico è in genere più preciso,
ma a pile scariche l'apparecchio smette di funzionare. Su quasi tutti gli
apparecchi sono previsti tempi che vanno da 1 secondo ad 1/1000 di secondo
(alcuni arrivano a 1/8000'') più la posa B, che permette all'otturatore
di rimanere aperto finche il pulsante di scatto è tenuto premuto.
La posa B si usa normalmente per le riprese notturne in cui i tempi di
esposizione superano tranquillamente il minuto.
Il mirino, permette di vedere cosa viene inquadrato dalla macchina, e quindi riportato sulla pellicola, generalmente abbiamo:
 mirino
galileiano; è un riquadro che simula la copertura dell'obiettivo
montato sulla macchina, non potendo essere mai in linea con l'obiettivo
in caso di riprese ravvicinate potremo correre il rischio di inquadrare
male il soggetto (errore di parallasse).
mirino
galileiano; è un riquadro che simula la copertura dell'obiettivo
montato sulla macchina, non potendo essere mai in linea con l'obiettivo
in caso di riprese ravvicinate potremo correre il rischio di inquadrare
male il soggetto (errore di parallasse). reflex;
è quello in cui l'immagine, che si vede passa attraverso lo stesso
obiettivo che sarà utilizzato per la foto. L'immagine passa attraverso
l'obiettivo e viene deviata da uno specchio, posto a 45° davanti la
pellicola, su di un vetro smerigliato sul quale sarà possibile controllare
l'inquadratura e la messa a fuoco. Su alcune macchine (in genere il medio
e grande formato) l'immagine viene vista al contrario e dall'alto in quello
che comunemente si chiama pozzetto, montando un pentaprisma (che ha il
compito di raddrizzare l'immagine come già avviene nelle reflex
da 35mm), la visione avviene direttamente nel mirino che normalmente da
anche altre informazioni, come il diaframma impostato, il tempo, ecc. Nel
momento dello scatto lo specchio si alza automaticamente permettendo il
passaggio dell'immagine sulla pellicola.
reflex;
è quello in cui l'immagine, che si vede passa attraverso lo stesso
obiettivo che sarà utilizzato per la foto. L'immagine passa attraverso
l'obiettivo e viene deviata da uno specchio, posto a 45° davanti la
pellicola, su di un vetro smerigliato sul quale sarà possibile controllare
l'inquadratura e la messa a fuoco. Su alcune macchine (in genere il medio
e grande formato) l'immagine viene vista al contrario e dall'alto in quello
che comunemente si chiama pozzetto, montando un pentaprisma (che ha il
compito di raddrizzare l'immagine come già avviene nelle reflex
da 35mm), la visione avviene direttamente nel mirino che normalmente da
anche altre informazioni, come il diaframma impostato, il tempo, ecc. Nel
momento dello scatto lo specchio si alza automaticamente permettendo il
passaggio dell'immagine sulla pellicola. biottiche;
sono apparecchi costituiti da due obiettivi con la stessa focale, in cui
uno permette la visione dell'immagine in un pozzetto tramite uno specchio
(come nelle reflex), l'altro fornirà l'immagine che andrà
ad impressionare la pellicola.
biottiche;
sono apparecchi costituiti da due obiettivi con la stessa focale, in cui
uno permette la visione dell'immagine in un pozzetto tramite uno specchio
(come nelle reflex), l'altro fornirà l'immagine che andrà
ad impressionare la pellicola.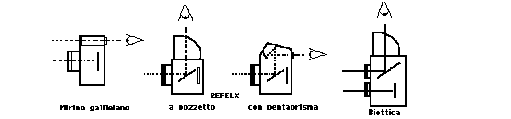
Riepilogo
grafico tipi di mirino
L'esposimetro, (è ormai presente in tutte le macchine) permette di misurare la luce presente nel campo inquadrato; generalmente abbiamo (la presenza di uno non esclude l'altro o gli altri) :
Fin qui abbiamo parlato delle
macchine tradizionali, ma vanno sempre più diffondendosi le
macchine digitali.
Diciamo subito che in realtà
non ci sono differenze particolari (nell’aspetto o nel tipo di mirino)
quello che cambia è che, al posto della pellicola, è presente
una cellula che ha il compito di leggere la luce e memorizzarla (su diversi
tipi di memorie) in formato digitale.
Tutto qui? Si e no. In effetti entrando nel dettaglio di differenze ne troviamo diverse, ma i principi fondamentali sono sempre gli stessi:
Le caratteristiche principali
Abbiamo detto che non sono
presenti (a livello teorico) grosse differenze con i sistemi tradizionali,
ed in effetti per quanto riguarda le modalità d’uso non ve ne sono
molte. In realtà quello che avviene “dentro” è, come ho già
detto, differente.
L’immagine (che sulla pellicola
viene memorizzata “attivando” dei cristalli di alogenuro d’argento che
saranno successivamente sviluppati e fissati attraverso un processo chimico)
nel digitale passa attraverso il sensore CCD (più o meno lo stesso
presente nelle telecamere). L’immagine viene “scomposta” come su di un
enorme foglio a quadretti dove ogni quadretto corrisponderà ad un
pixel. La quantità massima di pixel gestiti dal sensore è
indice delle sue prestazioni, maggiori saranno i pixel gestiti, maggiore
sarà il formato stampabile con qualità simile a quella
fotografica.
Per capire al meglio quali
sono le caratteristiche salienti, importanti anche per scegliere l’apparecchio,
dobbiamo soffermarci su :
Per risoluzione, nel caso
del digitale, non si intende la risoluzione dell’obiettivo (anche se, come
tutti gli obiettivi ne ha una) ma, come accennato, la quantità massima
di pixel che il sensore CCD riesce a gestire.. Torniamo ad immaginare il
sistema digitale come basato su tanti quadretti, dove ogni singolo quadrato
è il nostro pixel. Bene, se abbiamo 1680 pixel messi in fila per
1250 colonne otteniamo, dalla loro moltiplicazione, 2 milioni di pixel
che rappresentano la quantità max che il nostro
CCD riesce a memorizzare. Normalmente i pixel sono distribuiti in modo
tale che il formato finale dell’immagine sia simile a quello delle foto
(3:2), o, abbastanza spesso, a quello del monitor del pc (formato 4:3)
Per capire quali sono i
limiti del nostro CCD dobbiamo sapere che per stampare con qualità
fotografica una foto su un foglio A4 (equivalente ad una immagine 20x30)
dovremmo poter acquisire (cioè scattare la nostra foto) con un formato,
in pixel, pari a 2360x3540. Una stampa di maggiori dimensioni metterebbe
in evidenza (cosi’ come è per la grana di una pellicola) i singoli
pixel. Chiaramente maggiore è la risoluzione ottenibile, maggiore
sarà il costo dell’apparecchio.
|
(pixel gestiti) |
|
stampa |
|
850.000 1.300.000 2.000.000 3.340.000 4.000.000 6.000.000 |
1024x768 1280x960 1728x1152 2048x1536 2240x1680 3072x2036 |
9x6 11x8 10x15 18x13 19x15 26x18 |
Il supporto su cui memorizzare
le immagini è un’altra caratteristica importante, anche se
non ha impatti diretti con la qualità della foto e con la fotografia
in generale.
Il formato dei supporti
e la quantità di memoria disponibile possono rappresentare un grosso
limite per chi deve fare molte foto. Le card, dischetti, memory stick (e
chi più ne ha, ne metta) rappresentano i supporti su cui saranno
memorizzate le immagini all’interno del nostro apparecchio.
Il loro utilizzo è
condizionato da due valori: lo spazio disponibile e la grandezza (e quindi
quanto occuperà) dell’immagine.
L’occupazione finale dell’immagine
è un dato molto variabile (dipende dal tipo formato, tipo compressione,
dalla quantità di colori gestiti etc.) per cui vale la pena verificare
le tabelle che di solito corredano la macchina, mentre la capacità
di memoria delle card è di solito stampata e ben visibile su di
essa.
Una volta riempita la card
viene di solito scaricata nella memoria del nostro PC (è quasi d’obbligo
per chi usa la macchina digitale averne uno!!) e a questo punto può
essere nuovamente utilizzata, quindi se lavoriamo in casa o in studio,
la quantità di spazio a disposizione sulla card non rappresenta
una grande criticità (possiamo scaricare e ricominciare a
scattare in brevissimo tempo). Uno dei maggiori limiti del digitale è,
invece, l’autonomia durante viaggi. Infatti difficilmente con un paio di
card potrete fare più di un centinaio di foto di buona risoluzione
e per chi è abituato a scattare molto è un grandissimo limite.
Certo potreste portarvi dietro un bel pacco di card, ma visto che nessuno
ve le regala e il loro costo è ancora discreto, non mi sembra
una soluzione proponibile. Paradossalmente potrebbe essere più conveniente
portarsi appresso un PC portatile dove scaricare di volta in volta le foto
(una soluzione alternativa può essere quella di scaricare le immagini
su un nostro spazio su internet, ma va bene solo dove troviamo internet
point).
|
|
|
|
|